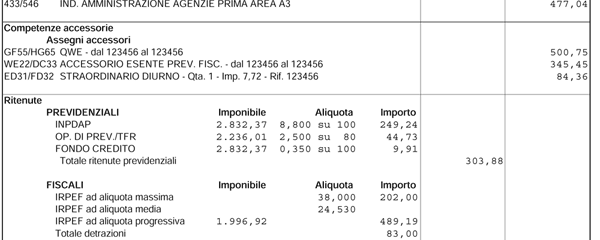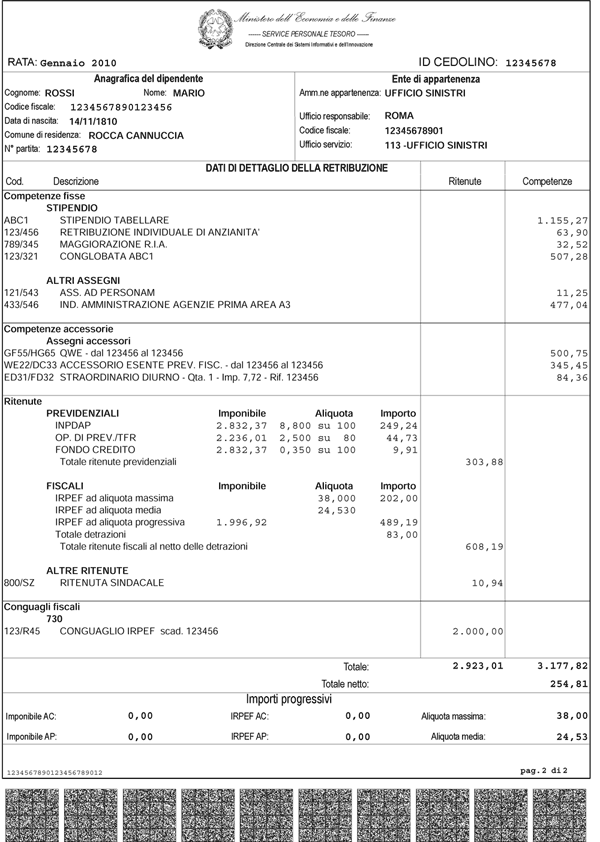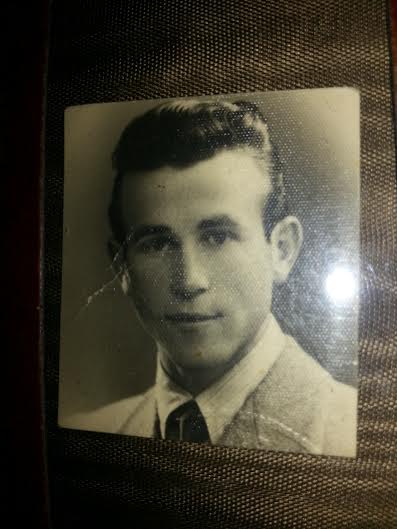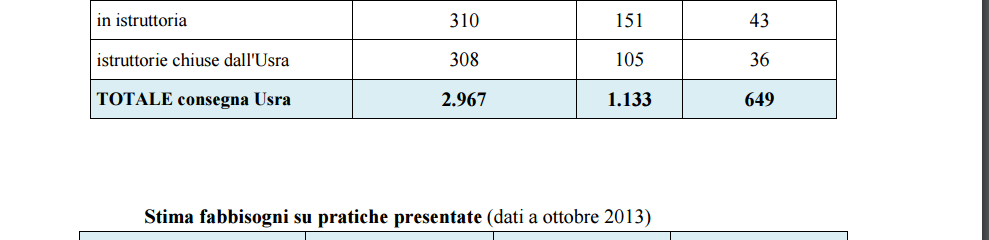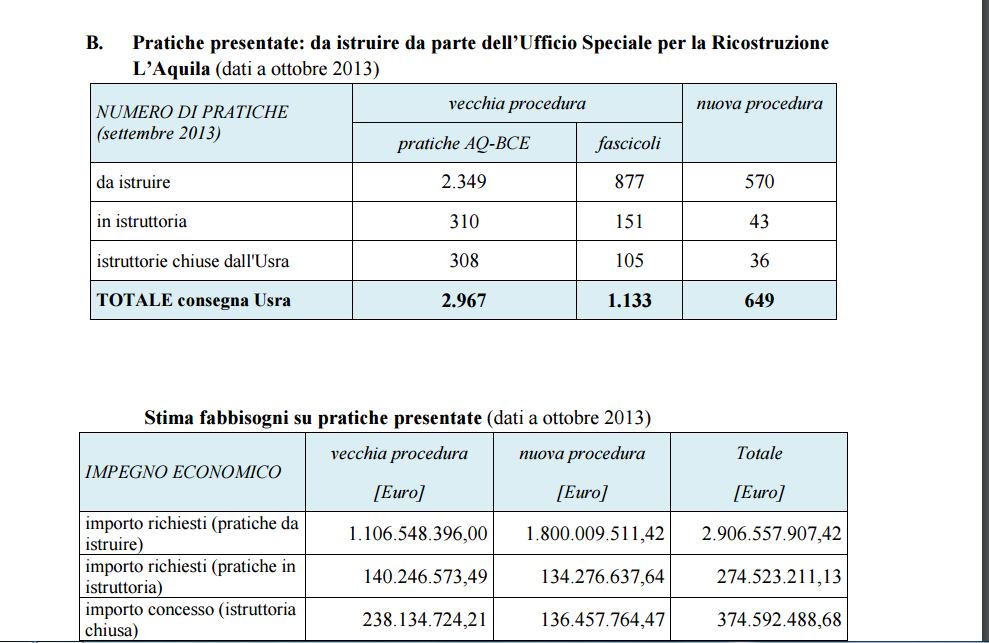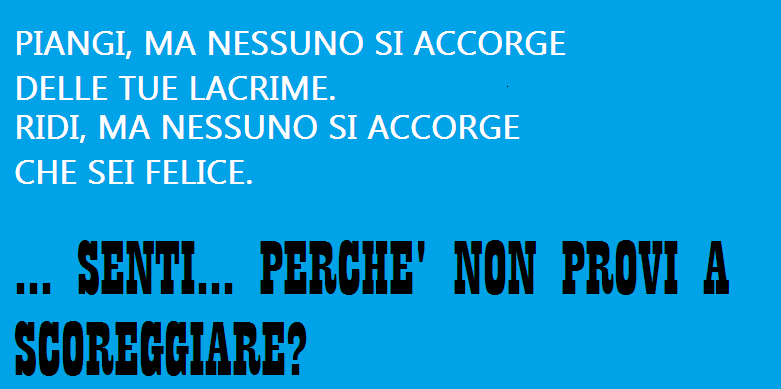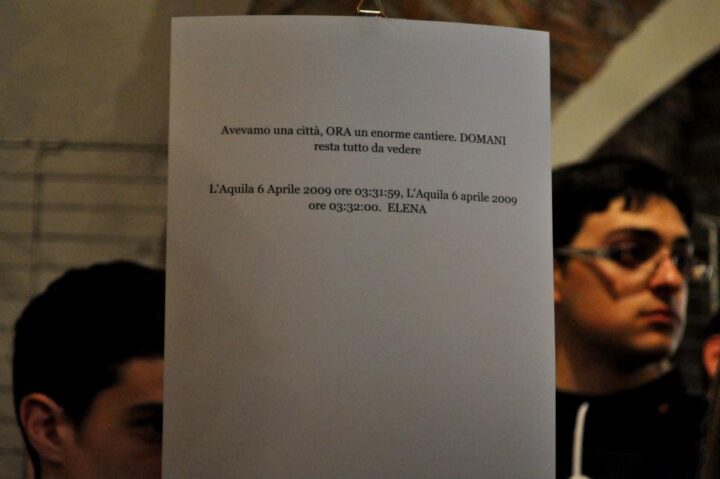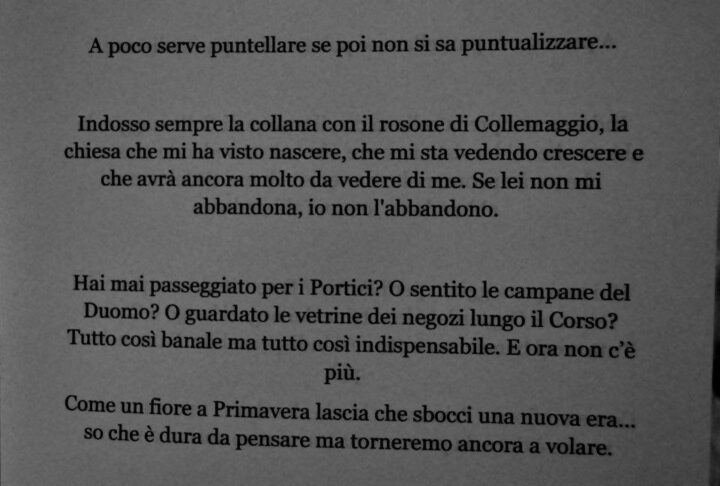Nonna Ester era sempre contenta quando suo nipote poteva accompagnarla dove lei aveva bisogno di andare. Lorenzo, poi, era il nipote preferito: fresco fresco dei diciott’anni e fresco fresco di patente, non aspettava altro che la madre gli dicesse: “Oggi devi portare la nonna dal dottore”. Una frase che gli provocava un nonsocché, una strana effusione di calore dallo stomaco fin sopra le orecchie. “E non farle venire un infarto” raccomandava laconica la madre. “Offréchete, vai tranquilla mà!”. Ultimamente l’orgoglio dialettale di Lorenzo era divenuto prepotente, per non dire insopportabile. La nonna, in questi casi, era arcicontenta. Sarà stata l’incoscienza, sarà stata l’età, sarà che i vecchi non si aspettano di essere eterni, ma la nonna era l’unica persona al mondo felice di salire in macchina con Lorenzo, e sfidare la morte. “Vieni qua giovanotto, ché ci divertiamo!” gli diceva strizzando tutti e due gli occhi. Scattante come un virgulto, prima di uscire di casa apriva il cassetto del comodino, prendeva un mazzetto di soldi senza contarli, e faceva capire al nipote, con una smorfia di aumm-aumm, che sarebbero andati “a sfrusciarseli”. “Nonna, vedi che oggi ti levo dieci anni!”. “Sì, i dieci anni che ti restano da vivere… “ farfugliava alle spalle la madre, certa che la nonna, mezza sorda, non potesse sentire. “Ma noooo…. la faccio ringiovanire di dieci anni!” precisava il ragazzo, che non arrivava mai a capire il sarcasmo materno. E nonna Ester, con la scusa del dottore, schizzava giù per le scale, agile e secca come era sempre stata, ragion per cui all’Aquila era nota come “La Marescialla”. Vedendoli uscire a braccetto, chiassosi e pieni di energia, c’era sempre da pensare: “Chissà come torneranno, anche stavolta…”. Già. Come si fa a stare tranquilli, quando un neo-diciottenne neo-patentato deve attraversare una neo-città? Troppi nei. Per non dire che non era una città qualsiasi, ma una città di nome L’Aquila, una Signora Città Terremotata. Da Marruci, dove erano sfollati, a San Gregorio, dove stava lo studio del dottore, era una vera a propria traversata: 35 chilometri, 7 euro di benzina e 55 minuti di macchina. Un sollucchero, la città diffusa. Che poi Lorenzo non sceglieva mai le higways, preferiva lebackstreets che scorrevano nel traffico limitrofo alla città vecchia, per fare un po’ di pratica di guida in qualcosa che somigliasse a una città vera. Adorava, per esempio, passare per viale della Croce Rossa, oppure per via XX Settembre: strade con un lontano odore di città, dove guidare si faceva interessante e ti illudevi di sfilare tra le case, invece di sentirti un pastore in un presepe. Sulle strade della città vecchia, per quanto penosa, la vista dei mazzi di fiori e dei poster con i volti dei ragazzi morti era venerata da tutti: passarci davanti era un modo per sentire i morti ancora vivi, tutti e 309. Gli aquilani avrebbero voluto vedere anche quelli della Zona Rossa. “Ci mandano i turisti con la guida, a guardare, e a noi, sangue del loro sangue, non ce li hanno fanno vedere!” si inalberava la nonna, facendo tremare un po’ platealmente la voce, quando diceva questa frase. Partivano come se si trattasse di un viaggio. Velocità di crociera: 40 all’ora. Climatizzatore: acceso. Percorso mentale: preciso ma, pronto a immediata, estemporanea revisione. Il ragazzo attaccato al volante, la nonna appesa alla maniglia del finestrino, per non volarsene via da una curva.
“Accosta annonna, quando vedi Alberto”. “E chi è Alberto?”. “Ma come, Loré, Alberto è il farmacista, devo comprare subito la colla per la dentiera!”. “E no, nonnaaa! Ma che ne so io, dove sta Alberto? Telefono a Chi l’ha visto?Dai, accontentati di un altro farmacista “. “Eh, ‘sti giovani… non conoscono i capisaldi della città!”. “Caposaldo della città? Il farmacista? Nonna jamo su!”. “Oh, Lorè, Alberto era meglio del dottore! La colla per la dentiera che compravo a Capopiazza…” “Scì scì, nonna, Capopiazza non c’è piùùù! C’è stato il terremoto, te lo ricordi? Tra venti minuti però c’è una bella farmacia! Non hai voluto cambiare dottore, almeno cambia il farmacista!”. Non c’era stato verso di farglielo cambiare, alla nonna, quel dottore. S’era faticato per farle cambiare il supermercato, il pizzicagnolo, il parrucchiere, il fruttivendolo, il pesciarolo, ma il dottore, quello, non ci fu verso. Nelle nuove zone, nei nuovi negozi, nei nuovi giardini, la nonna si guardava intorno spaesata: “E tu chi sei? Il mio parrucchiere si chiama Daniele! Come mai non viene lui a farmi i capelli?”. Tutti le mentivano pietosamente: Daniele era andato al bar, era in ferie, era andato un attimo a casa… Lei si lasciava prendere in giro, faceva l’aria piccata e usciva dicendo: “Se Daniele non torna, io cambierò parrucchiere! Lui sì che sapeva come prendermi per i capelli! Ahahahah…”. Era la sua battuta preferita. Poi, la volta successiva, docilmente si lasciava portare dal parrucchiere sotto la nuova casa, per non dare troppi fastidi ai parenti. Ma Lorenzo era certo che stesse fingendo. “Preferisce sembrare rincoglionita, ma io lo so che sta prendendo tutti per i fondelli”, pensava sempre con aria di complicità. Il dottore, medico della famiglia da trent’anni, s’era rovinosamente trasferito a San Gregorio. E la nonna, testarda, ci si faceva accompagnare al bisogno, e se nessuno voleva, chiamava un bel taxi. Ma ora c’era Lorenzo che voleva! Certo, era una bella traversata…
Ogni volta, arrivata alla quarta rotatoria, la nonna diceva sempre la stessa, fatidica frase: “Certo che prima L’Aquila era piena di salite e discese, mo’ è diventata piena di curve, ahahahah!”. E rideva di gusto, per poi aggiungere: “Ma com’è? ‘sto terremoto ha cambiato la conformazione del terreno, eh, Loré?”. “Sci scì, no’, ha cambiato la conformazione del terreno!” la prendeva in giro il ragazzo. “Mo’ però è pure bella, L’Aquila, ve’ Loré?” “E certo che è bella! E’ bella, è bella! A me mi piace lo stesso! Guarda!… Si fila che è una meraviglia! Pare tutta ‘n autostrada!”.
“Ecco la farmacia, no’, vedi che ce l’abbiamo fatta? Mo’ guarda come parcheggio eh, no’, ti faccio un parcheggio da manuale!”. Lorenzo sistemava la sua Fiat Uno nell’ampio piazzale davanti alla farmacia come se si trattasse di un trattore da infilare in una rimessa troppo stretta. “Ma addo’ sta’ la farmacia, Loré?” “Qua, nonna! Dentro al container, dai, vieni, ti accompagno”. “No, aspettami qui annonna, faccio da sola!”. Non voleva mai essere presa sottobraccio, La Marescialla. Per questo i figli la sgridavano sempre, mentre Lorenzo la considerava una gran figa. “Bella no’, non ci sta nessuno, evvai!”. I container, qualsiasi cosa vendessero, pure le medicine, davano sempre un’impressione di disordine e di sporcizia. La nonna, uscendo, esclamava: “Temé, come sta messa la farmacia di Capopiazzaaaa!”. “Eddaje co’ ‘sto Capopiazza, nonna, stiamo ancora a San Sisto!”. “Loré, mi devi portare al Bersagliere! Mi servono le canottiere e pure le mutande!” “Ma dai, nonnaaaa, il Bersagliere no, per favore!” “Sì invece! Dove sta Renato? io lo voglio rivedere! fai contenta annonna, su”. Così dicendo, gli allungava un bigliettone da venti euro, che Lorenzo accettava, simulando un accenno di reticenza, come vuole la buona educazione. Per incoraggiare la guida timorosa del giovanotto, la nonna aggiungeva poi qualche commento del tipo: “E’ ancora bella, L’Aquila, eh Lorè? Vedi come si fila? Si fila proprio bene”. “Seee… dici che si fila? Ah no’, ’sto tizio qua davanti avrà 108 anni, e porta pure il cappello, altro che si fila!” “Eh, se avessi la patente io! Anch’io porterei la macchina, e mi vedresti sfrecciare proprio come questo signore!” “Sfrecciare? Nonna, questo va a 20 all’ora! Abbiamo una coda dietro che arriva fino a Tornimparte! Altro che signore, questo è Mister Magoo!”. “… La porterei pure io…” continuava tra sé la vecchietta “la porterei eccome, la macchina. Mica si può dare fastidio ai figli, dopo quello che è successo!”. Alla rotonda del Torrione, la nonna riconosceva sempre con entusiasmo il paesaggio, che non era molto mutato da prima del terremoto, anzi sembrava migliorato. “Rallenta rallenta! Ecco la statua del Terremoto!” e si faceva il segno della croce. Alla rotonda successiva, regolarmente diceva: “Ma qua non ci siamo già passati?”. Però notava bene la nuova statua, e si segnava ancora, un po’ intristita. “Su su, nonna dai, mo’ nonripiàgne eh, mannaggia!”
A Lorenzo piacevano, i vecchi. Erano proprio belli. Gli mettevano allegria. Tutto il contrario di quelli che lui chiamava i “quasi-vecchi”. I “quasi-vecchi” erano quelli abbastanza vecchi da essersi dimenticati dei calci nel sedere che avrebbero voluto sferrare ai loro figli quando erano adolescenti. Calci che, ora, da quasi-vecchi, riservavano con piacere, confusamente e senza scrupoli parentali, ai figli degli altri, Così, per pura, inconsapevole vendetta. Soltanto una meravigliosa presbiopia senile avrebbe poi aperto i loro occhi, tra qualche annetto. Con un po’ di fortuna sarebbero potuti diventare perfino come nonna Ester. “Eh, devi avere pazienza con i vecchi, Lorè! Hanno i loro tempi, e non possono chiamare per ogni cosa figli e nipoti, sparpagliati come stiamo, uno a destra, uno a sinistra…. Oh oh… Rallenta rallenta! Ecco un’altra statua del terremoto! Vedi, vedi quant’è bella?… ”. Altra croce. “Oh, nonna! La fai finita co’ ste croci? Mi innervosiscono la guida, eddai! E poi mi viene da togliere la mani dal volante, porca miseria!”. “Eh, figlio mio! Su, vai, vai, che sei tanto bravo!”
Solo la nonna diceva a Lorenzo che era bravo, solo lei, specie dopo il terremoto, dacché Lorenzo aveva iniziato a studiare poco e niente e a scuola andava proprio male. Così, senza nessun motivo, andava male e basta, non c’entrava niente il terremoto, né il centro commerciale, né i portici o la sua cameretta senza più le collezioni di Dragon Ball Zeta, disperse anche loro sulle strade della California. Era solo che non gli andava di studiare. I quasi-vecchi, ogni tanto, guardavano lui e i suoi compagni con gli occhi che dicevano: “Mah”. Faceva comodo lasciar credere ai quasi-vecchi che la colpa era la mancanza della casa, ma era il copione. Ogni tanto qualcuno in città se ne usciva a chiedere “ai ggiovani” di che cosa avessero bisogno. Locandine, fotografie, strette di mano, qualche progettino, articoli sui giornali, poi tutte le promesse si spegnevano come un cerino sotto a uno sputo. I ragazzi stavano al gioco: intervistine, due o tre foto in atteggiamento da macho, e gli adulti erano tutti contenti di aver fatto il loro dovere, poveracci. Però qualche quasi-vecchio in gamba, ogni tanto, da cui sentirsi capiti, si trovava. Come il professore di Scienze. Quello sì, valeva la pena accostarglisi. Gli bastava guardarti in faccia al mattino per capire se era aria. E poi sapeva sempre come tirarti fuori dal sacco. Ci riusciva sempre. Non diceva mai “i ggiovani”, lui. A volte Lorenzo ci passava la ricreazione in cortile, a vederlo fumare e a chiacchierare: ci stava bene perché a lui non usciva dagli occhi la frase: “Questo non combinerà mai niente”. Era l’unico come nonna Ester, che qualche volta gli diceva addirittura che era tanto bravo, e lui si sentiva gonfiare piano piano come un tacchinello.
“Non c’hai paura di venire in macchina con me, nonna?” “Paura? E di che? Sei proprio bravo, guai a chi dice di no! Fai questa bella traversata per portare la nonna dal dottore!”. Una volta arrivati, la nonna scendeva e faceva la sua visita. Lorenzo, nel frattempo, se ne stava prudentemente nascosto. Nei giardini davanti all’ambulatorio, infatti, c’erano sempre un sacco di bambini a giocare, e con loro inevitabilmente c’era l’altra categoria di persone dalle quali Lorenzo rifuggiva con lo stesso terrore con cui un gatto scappa via da un asilo: i “Genitori-di-figli-piccoli”. I Genitori-di-figli-piccoli aborrivano i ragazzi della sua età, li guardavano con disprezzo profondo. A trovarseli davanti, infatti, e a vederli darsi spintoni, fare gli scemi, vestiti come i parenti poveri di Naruto, sbrindellati, scaciati, con le maniche sempre troppo lunghe e i pantaloni sempre troppo calati, i Genitori-di-figli-piccoli si innervosiscono sempre. Stringono a sé le loro creature, come per paura di un orribile contagio. “Via, via, brutti fannulloni! A studiare, via! Alla vostra età, io… ehmmm… mio padre… ehmmm… mio nonno… Insomma, via!”. I ragazzacci, sghignazzando, nella stupidità che caratterizza l’età ingrata, ci credevano, alla storia del padre e del nonno, che invece erano stati adolescenti pure loro, e magari pure peggio di loro. ”Ah, se fossi io vostro padre!”, aggiungevano i Genitori-di-figli-piccoli. Non immaginavano mai che lo sarebbero stati molto presto. E allora sì che avrebbero iniziato a ingoiarsi quei calci che ora prudevano sulla punta dei piedi.
La nonna usciva sempre dall’ambulatorio con un mazzetto di ricette e la faccia soddisfatta: e così iniziava la traversata al contrario, sulla via del ritorno, rotonda dopo rotonda, pensiero dopo pensiero. “Ecco la statua dell’angelo!” diceva a un certo punto la nonna, spiccando la mano dalla maniglia, come per segnarsi di nuovo. “A nonna che fai? quella è l’aquila di bronzo del reggimento degli Alpini!” “Uh, e che ne so! Loré… A volte non mi ci raccapezzo… Non mi ci raccapezzo più…”. La stanchezza, a quel punto, creava un piccolo corto circuito nel cervello della nonna. Faceva una lunga pausa e poi tirava una specie di singulto, con lo sguardo perso nel finestrino: “L’Aquila s’è spallata, Loré!”. Solo in quei momenti di confusione la nonna sembrava realizzare lucidamente l’evidenza. “L’Aquila s’è spallata”. Lorenzo, nel suo primitivismo, avvertiva che dopo questa frase la nonna sentiva una cosa allo stomaco che la tirava giù giù verso il tappetino di gomma, così cercava di distrarla come meglio poteva. “Guarda no’! Guarda che bei cantieri! Le case sono tutte incappottate, no’! Piano piano si rifanno, lo vedi no’? Sei contenta?”. “Oh, che bello, Sì sì, piano piano! Ci vuole il tempo suo. Certo io casa mia… chissà se la rivedo, eh Loré… Mi ci porti a fare un saluto? Dai Loré, poi ci prendiamo le pizze!”. Ma Lorenzo era incorruttibile. Come ce la portava, d’altra parte, in via Tre Spighe? E ogni volta se ne inventava una nuova. “Nonna, lascia perdere la casa, andiamo a prenderci il gelato!”.
Tornavano che era tardi. Come sempre, il quadretto si presentava uguale a se stesso: Lorenzo distrutto di fatica, la nonna con la faccia stralunata dal paesaggio straniero, e infine la mamma che, con il solito pessimo umore, saltava alle conclusioni, le solite, sbagliate.“Lorenzo, ma come devo fare con te? Guarda come hai ridotto la nonna!”. Ma Lorenzo sapeva, nei suoi stupidi diciotto anni, che la colpa toccava comunque e sempre a lui. E sapeva anche, con assoluta certezza, che la tristezza della nonna, l’amarezza della madre, stavolta, almeno stavolta, non erano tutta colpa sua.
__________________________________________
DRIVING WITH JIM!!!!!