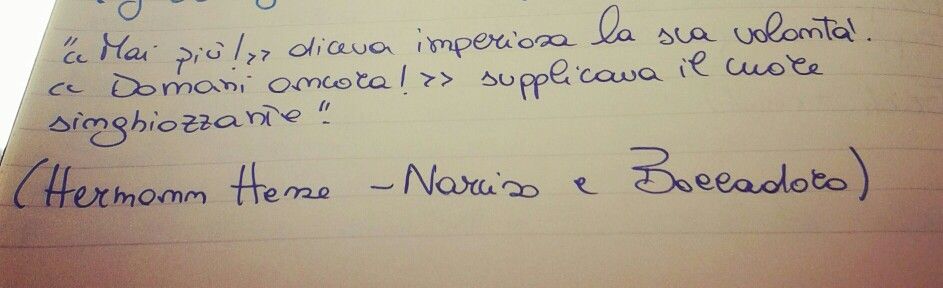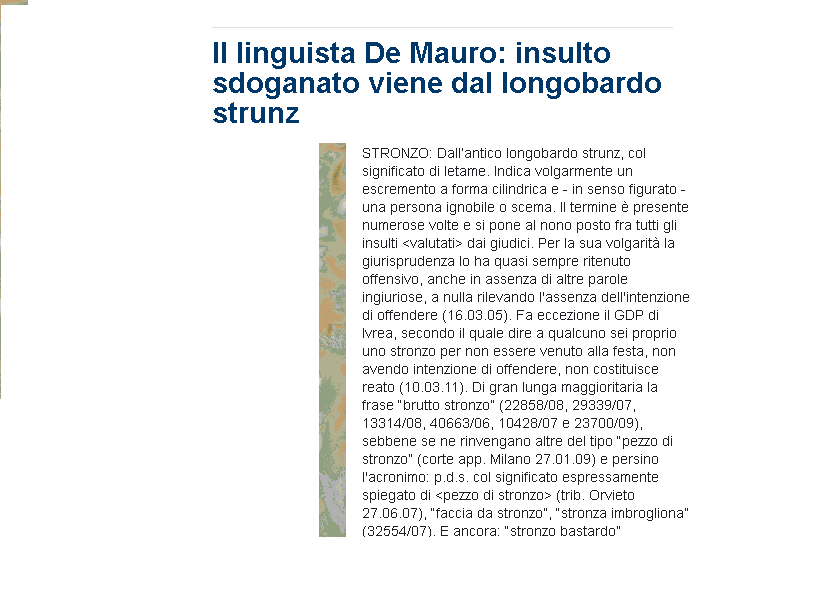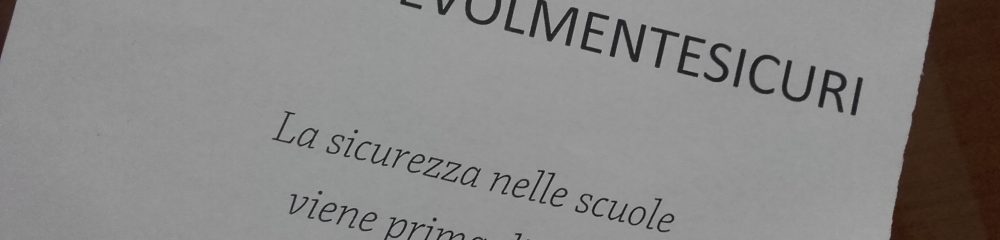“Sono largo, contengo moltitudini” (Walt Whitman)
Fabrizio (chiamiamolo così) sta al quinto anno, ma è ancora minorenne, 17 anni. È un sognatore, uno di quelli che quando entri in classe già gli daresti un sacco di schiaffi, a prescindere, perché sta sempre sotto al banco, invece che sopra.
Tuttavia non mi dispiace una classe dove non siano tutti allineati e compunti, mi piace che i ragazzi crescano gomito a gomito con le loro reciproche, infinite differenze. Per apprezzarle e salvaguardarle, poi, anche da grandi.
Oggi però è accaduta una di quelle piccole storie che non mi sono mai piaciute, in cui mi sento di obiettare in coscienza: ed ecco perché sono qui, e sono triste.
Fabrizio si mette contro un sacco di coetanei per via della sua impopolare popolarità: è un rapper, ha un certo numero di followers. Si candida alle elezioni scolastiche, ma fa il furbetto in campagna elettorale: posta un video senza sonoro, con la sua faccia in primo piano come un pesce in un acquario e sotto ci scrive “silenzio elettorale”, violandolo. E cosi lo trombano, con pubblico ludibrio e depennamento immediato dalle liste.
E lui che fa? Prima vuole morire. Poi incanala la delusione nell’ ironia, e ci scrive su un rap dal titolo “Depennatemi”. E gli passa.
Poi arriva l’autogestione. E lui fa una genialata delle sue: dà manforte a un amichetto del primo anno che scrive su facebook: “Se raggiungo cento like sotto la mia foto, mi faccio tagliare i capelli durante l’autogestione”.
I like naturalmente arrivano triplicati, e lui, l’Idiota (in senso Dostoevskijano, naturalmente), organizza lo spettacolo.
L’esibizione viene acclamata da tutta la popolazione scolastica sui social: tagliarsi i capelli in pubblico o per scommessa in questo caso non ha certo la valenza simbolica paolina (att., 18,18), o biblica (GdC 13-18), o francescana (Proc 12,4: FF 3088), forse non ha neanche la valenza che mettono in rilievo gli psicologi (cfr. Marie Rose More, Gli adolescenti si raccontano. Genitori in ascolto dei propri figli, Cap. “Ragazzi, attenti ai capelli!“). Forse in questo caso è stata solo una faccenda demenziale, non saprei, dettata da manie di protagonismo tutte adolescenziali, oppure ha a che vedere con una sorta di “battesimo” dei rapper. Non lo so.
Quello che so è che il ragazzino piccolo se li fa tagliare da Fabrizio, suo amico e adeguato MC (maestro di cerimonia, nella cultura giovanile sulla quale è necessaria una doverosa documentazione): pare che il piccolino ne abbia parlato anche con i genitori, mettendo la cosa in modo da ottenere un silenzio-assenso del tipo “contento tu“, come sovente accade ai genitori che vedono l’autogestione come un carnevale che dura sette giorni di infinita pazienza.
La cosa accade, è una cosa stupida, ma come tutte le cose stupide fa audiens. A molti piace, a qualcuno non piace per niente.
A chi? Ad altri ragazzi spettatori, che denunciano il fatto subito dopo. Inizia a circolare in maniera violenta e aggressiva la versione di Barney: atto di bullismo del grande sul piccolo, coercizione di volontà, plagio, violenza, gesto da naziskin. Girano parole grosse, ma piacciono tanto, perché riempiono la bocca e ti fanno sentire protagonista di un film.
Il film finisce in tragedia: si chiedono provvedimenti disciplinari esemplari, e inizia il gioco al rialzo, anche tanti altri vanno puniti, per esempio i ragazzi che dovevano vigilare e che invece se ne sono andati al bar, tornando a scuola solo per il contrappello, proprio come fanno i furbetti del cartellino. E chi li denuncia? Altri ragazzi, che chiedono pene severe, in un’atmosfera che sempre di più ricorda la fattoria degli animali e la caccia alle streghe, o il signore delle mosche e la guerra dei bottoni.
Sono cose che non si fanno, e non so quale sia la più grave. E vanno bacchettate, tutte. Così è stato, tutti i ragazzi imputati hanno capito di avere sbagliato, e hanno chiesto umilmente scusa. Saggio sarebbe stato non assecondare mai questo clima, e punire tutti come si farebbe con i figli: a letto senza cena, nota a registro, voto di condotta al minimo sindacale.
E invece no: si chiede la testa di qualcuno, a imperitura memoria. E la testa è quella di Fabrizio, il rompiscatole.
Punirlo, sì, anche perché sia di monito agli altri e perché il fatto non succeda mai più nelle prossime puntate. Punirne uno per educarne mille. Sacrificare una vita serena sull’altare del funzionamento di una macchina che non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno.
La scuola è un microcosmo, ma è un microcosmo che non può essere paragonato in toto a quello sociale: non è un riformatorio, è un ambiente protetto, ci sono regole volte alla rieducazione, alla formazione, votate all’inserimento e non all’esclusione. Quell’uno, quel solo, ha un valore. La sua vita, ha un valore.
Come si sentono adesso quei ragazzini? E come si sentono i furbetti del cartellino, sapendo che loro reato è stato considerato una ragazzata rispetto a quello del parrucchiere? e come mi sento io dopo una giornata in cui avrei dovuto forse esporre con più incisività il mio punto di vista? come mi sento sapendo che la spirale di violenza non si spezza, ma si alimenta? Sì sì, lo so, adesso tutti direte che sono la solita buonista, ormai si usa la parola buonista ogni volta che si assiste a una difesa d’ufficio. Ma questo a voi sembra buonismo, a me quello sembra giustizialismo, non giustizia. A scuola si è aperta una caccia al bullo che fa finire nella rete anche il famoso Idiota (sempre in senso dostoevskjiano), e finiscono sul rogo un sacco di ragazzini border che, a questo punto, buttati giù dal bordo, ma nella parte sbagliata, non avranno più nulla da perdere, e gli toccherà fare i bulli per davvero.
E mi addolora l’aria divertita con cui tutti quanti hanno aspettato lo spettacolo, per poi denunciare alle autorità competenti. Mi ferisce che nessuno abbia pensato ad evitare il fatto, per evitare la punizione. A prevenire, piuttosto che a curare. Ora abbiamo dovuto punirli per forza, perché a scuola c’è la certezza della pena. Solo a scuola, con i ragazzini minorenni.
Che imparino le buone maniere con la giusta punizione. Ecco. Facciamoli, volare, gli stracci, se è l’unico modo per salvare quanti Fabrizio ci sono nelle nostre scuola d’Italia. Facciamoli volare, perché ci stiamo male in tanti. Perché lavoriamo con i ragazzi e non ci piace questo clima conflitti e di ostilità. Perché non possiamo sempre tacere. Perché tanti di noi non si vendono per trenta denari di bonus. E perché un oppositore corretto e leale ti rende migliore, mentre cento servi sciocchi ti confermano nell’errore.
Le orecchie d’asino non si mettono più dai tempi di Franti, e tanta gente ha dato la propria vita, in un passato non così lontano, perché a scuola tutti potessero avere diritto a una riabilitazione. Ma l’aria che tira non è per niente bella, per noi insegnanti della vecchia guardia
Fareste bene a mandarci in pensione, noi che abbiamo conosciuto Don Milani e Berlinguer. Fareste bene, allora fatelo. Fatelo con un calcio. E poi rimettete bene in vista quel vecchio cartellino che c’era prima dei Decreti Delegati: “Non parlate al conducente”. Per noi, la scuola sarà sempre di chi la abita, non di chi la conduce. Chi comanda, si faccia servo, diceva don Lorenzo Milani. Ah, e diceva anche che obbedire certe volte non era per niente una virtù. Ho detto virtù? Deve essere una di quelle parole che Orwell prevedeva sarebbero scomparse dal vocabolario della Neolingua.