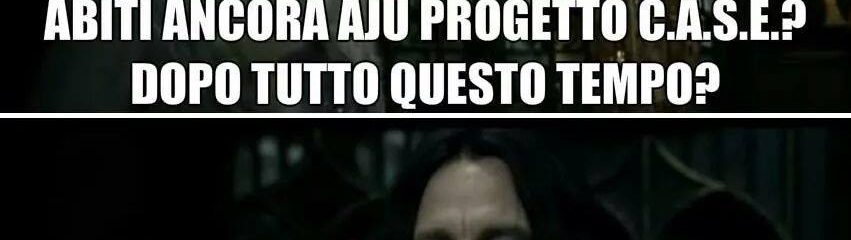Un ricordo mai scritto di due anni fa
6 Settembre 2016
Tornare è una parola che t’imbroglia.
Dovunque torni,
quando torni,
sarà come andare al cinema
a vedere uno stupido film.
Con la memoria si torna,
ma a che serve?
Se stai cercando qualcosa,
e torni indietro,
la stai cercando nel posto sbagliato.
Volver 1
Io non vedevo l’ora di tornare. E me l’ero immaginato in mille modi, tutti diversi e tutti belli. C’era sempre che avrei appeso la bandiera neroverde alla finestra. L’avrei fotografata, e dopo i lunghi anni di silenzio, ecco, sarei tornata a dire. Ma in mezzo c’è stato un oceano di tempo in cui sono avvenute mutazioni. La bandiera nero-verde è lì in un angolo, piegata. La palazzina è ancora mezza vuota, solo io e Carla, arroccate lassù in cima, laddove prima c’erano i bei coppi.
Per sette anni ero tornata con la mente in un posto che non c’era più, da un altro posto, che era immerso in una dimensione senza tempo.
Volver 2
La piazza di Sant’Elia era come tagliata a metà dalla Statale. Tutto era fermo in quella piazza col progetto CASE sopra al colle, esposto al vento, zitto come un dormitorio. Un giorno dei ragazzi portarono a spalla una panchina sotto la mia piastra. E da allora ogni sera, contro il muro, si mettevano a suonare le chitarre fino a notte fonda. Era bello. Bellissimo. “E basta co’ ‘sta panchina!” ogni tanto qualcuno brontolava “e che è? un centro sociale?”
Uno dei gatti nati a primavera correva pure lui alla panchina, quando vedeva gente. Gli davano del cibo, e il gattino si lasciava coccolare, chiedendo in modo lamentoso, un miaaaoooo lunghissimo, insistente. Era una femmina. E visto quel suo modo lagnoso di chiamare, io la chiamai Melania.
Una mattina sotto la panchina ci trovai Melania con la testa fracassata. Mi avvicinai, aveva gli occhi semichiusi. Sotto la testa, una piccola pozzanghera di sangue. Alcuni dissero che l’avevano ammazzata. Altri che l’avevano investita nella notte, e che s’era trascinata sul selciato fin lì, sotto la panchina.
Volver 3
Una casa di cemento è un’altra cosa. Se è una casa degli anni Sessanta poi, è piena di stranezze, e quando ci torni con la mente le rivedi tutte. Il locale dove stava la caldaia, per esempio. Era la meta delle prove di coraggio dei bambini, con quel buio pesto, con quella cosa enorme, nera come la pece, rumorosa, pericolosa, a dire dei grandi, ma per noi aveva il fascino che hanno certi tipi di paura. La vedo, vedo le cantine, vedo il locale dei serbatoi d’amianto dove Paola e io giocavamo ad estrarre clorofilla, passando ore e ore dei nostri pomeriggi a pestare foglie fino a far uscire un succo bavoso, che poi distillavamo dentro ai bicchierini delle bambole. Gli occhi sono rimasti quelli, ma non riconoscono. S’era inclinata di 12 centimetri, la casa. Dopo tre anni, intuendo quel garbuglio che sarebbe stato, alcuni hanno venduto. Prima che i Vigili la buttassero giù, il 4 ottobre del 2010, qualcuno scrisse su una mattonella del portone: “Torneremo ricchi e vendicativi”.
Volver 4
Su un muro del Progetto CASE c’era scritto: “Tornerò qui a trovarti”. Qualcuno che se n’era andato e che, come se fosse passato finalmente il tram, l’aveva preso. Al Progetto CASE non era tanto male, ci stavi dentro che non sembrava la tua vita: sembrava solo tempo. Ciò che rendeva squallido il contesto era il morale: una tristezza, una malinconia strana, la faccia dei vicini sconosciuti, il vergognarsi di girare – come si dice qui – con gli stracci in collo. Il nulla intorno, per partito preso. Ma ce ne fregavamo, felici d’esser vivi. Innervosiva tutti, quella nostra strana resilienza: gerani sui balconi, arredi, begli angolini decorati, roba. Com’è che si dice? Quando devi stare a lungo dentro a un tunnel, arredalo. E noi l’arredavamo. Un giorno vennero a tagliarci le paratie con le cesoie. Le trovammo buttate sui balconi, così, perché non era un bene che i terremotati s’adattassero in quelle case in scomodato d’uso. Boh. Qualcuno un giorno mi spiegherà che male facevamo, e a chi.
La gente non legava. Gli stranieri, per lo più macedoni e rumeni, non erano più stranieri degli aquilani stessi gli uni agli altri. Adesso, quando qualcuno se ne andava dopo sette anni, non scriveva più “Tornerò qui a trovarti”. Se ne andava e basta, senza salutare, incavolato nero, come se volesse qualche cosa indietro che nessuno avrebbe potuto più ridargli.
Volver 5
Torno sul colle. Torno, per forza, vengono a staccare i contatori per fare le volture. Dentro la casa nuova non riesco ancora a stare, ancora non la so godere. Soffoco, dentro al cemento. Mi manca l’aria, mi manca il vento che si incanalava dentro ai ballatoi. Le travi che ora emergono potenti dal soffitto non fanno che sussurrare notte e giorno “terremoto”.
Torno, e torna pure lui col suo 6.0, poco lontano, a buttarmi ancora fuori. Rimpiango quasi il legno, e il limbo caldo che lì t’avvolgeva in quell’attesa del tornare, limbica come una gestazione.
Torno sul colle, e aspetto, seduta sopra la panchina di Melania. Faccio una scemenza: guardo la finestra da cui un giorno all’alba vidi l’ambulanza raccogliere il corpo dell’anziano signore che s’è buttato giù dal terzo piano. Guardo il giardino di Maria, deserto, e un rampicante con i fiori azzurri che lei aveva piantato e che è sopravvissuto, avvitandosi ai pali delle scale. Ho visto nascere bambini, qui, e fiocchi azzurri sulle porte. Ho visto morire le persone, e funerali partire da qui sotto. Ho visto una festa di nozze che non mi scordo più, con i fuochi d’artificio in mezzo al prato, il brindisi, la serenata. La neve, il sole, un sacco di animali tenuti come fossero persone. E i rapaci, all’alba, che stridevano vicino alle finestre. Noi come api, ognuno nella cella. Si usciva per spiare la città, misurare ogni progresso. Ti stiamo vegliando, madre, per quello che possiamo. Ecco, ti regaliamo gli anni migliori della nostra vita.
Nel Settecento, dopo il terremoto, i governatori chiusero e barricarono le porte della città per impedire che restasse spopolata. Oggi sembra il contrario esatto. Sembra che tutto dica di lasciare il campo. E noi ci chiedevamo muti: “a chi?”. Ce lo dirà la Storia, a chi.
E poi tra qualche secolo, dopo un terremoto, la gente dirà “Ma lo sapete che nel 2009 all’Aquila lasciarono le porte troppo aperte?”
Mi alzo e taglio l’ultimo filo, proprio come un cordone. Vedo un gatto grigio, lamentoso, che somiglia tanto a Melania e magari è proprio figlio suo. Mi piacerebbe portarlo via con me, ma non lo faccio.
Anatolia mi tiene via la posta, dovrei andare da lei a prenderla, ma è come se fosse indirizzata a qualcun altro che non sono io, e così non faccio neanche questo.
Risalgo in macchina.
Volver 6
Un giorno mi dissero che era finita la guerra. E’ finita! puoi tornare! puoi tornare alla civiltà dopo la barbarie! Questo mi dissero. A me sembrò più civile l’altra parte, però non si può dire. Mentre si ricostruivano le case, noi si restava zitti, e si guardava ai nostri cantieri con i lucciconi, sognando che quei soldi degli Italiani fossero spesi pensando a noi, solo a noi, che pagavamo tanta civiltà al prezzo di più di sette anni della nostra vita. Sembravano soldi falsi, da come la gente ne parlava. C’avevi la casa vecchia, e mo’ te la ritrovi nuova, che te piagni? Che piango? E tu che vuoi? Morivi di fame e mo’ ti ritrovi i soldi. Invece di guardare me, fai le tue cose piuttosto, e falle come le devi fare. A te sembrano soldi falsi quelli che hanno rifatto la mia casa? perché non escono dalle mie tasche? Ma sono soldi veri. Si vede dalla fretta con cui te li sei messi in tasca.
Insomma mi avevano detto che era finita la guerra, e invece c’era ancora da sparare, ma io di munizioni non ne ho più. Ho civilizzato quartieri, svuotato garage, case finte, case vere, due, tre, quattro volte in sette anni. Tu in pace, e io ancora in guerra, e chissà la guerra quanto dura ancora. Tu che parli di tutto, ti arrovelli per salvare le foche, dibatti sui criteri architettonici sulle cascate dello Zimbawe. E me, me, che sto qui, me che ti ho fatto ricco, non mi vedi.
Volver 7
Io non sono più io, e la casa non è più lei. Bisogna ricominciare.
Ma uscire da quel limbo ti riporta in vita. Perciò, amico sfollato che sei ancora sfollato, cerca di maledire ogni giorno di ritardo, e chiunque ti abbia negato anche un solo giorno del tuo rientro a casa: tornare, tornare in una casa vera, questa è l’unica cosa importante, e non lo capirai che quando te ne andrai da quella melassa in cui ti trovi impasticciato adesso. Non potrai riprenderti il passato, ma se torni in una casa vera, potrai riprenderti il presente, il tempo vero della vita, e spiare la città vecchia non più da un dormitorio, ma da una casa. Chi non ci è passato, non sa la differenza. Perciò tu, che ancora ci sei dentro, spingi sul cantiere, spingi! Anche se non ti fanno stare, tu “committente”, vai lì sotto, fatti vedere, chiedi cose, insomma spingi, spingi per tornare. Ti chiederanno ancora un mese, poi un altro, e un altro ancora. Tu non ci stare, e ricordati che non sono pochi mesi quelli che ti stanno chiedendo: sono sette anni e pochi mesi, otto anni e pochi mesi, nove anni e pochi mesi. Nulla andrà come speri, non sognare, sii vigile e presente: nessuno ti sta regalando niente, anche se vorranno fartelo credere. E’ la civiltà del Paese in cui casualmente sei nato, che ti regala di nuovo quello che la catastrofe ti ha tolto. Si chiama civiltà: non darla via, chiedi, pretendi. Magari non servirà a niente, ma tu fallo. Ogni scelta era l’unica che potessi fare, in quel momento. Quando la casa sarà finita, solo allora avrai le competenze per incominciarla. E’ sempre così. La maledizione che si usa da generazioni e generazioni su questa terra tremante: “Te putissi fa’ la casa”.
Volver 8
Il cemento non mi soffoca più.
Sopporto le travi a vista.
Sopporto perfino le scosse.
Inizio a fidarmi, e non ci torno più al progetto CASE. Ora vorrei che fosse spallato, cancellato via, spianato con le ruspe.
Vorrei non vederlo mai più. Lo odio.
Quando ci finii dentro, ero in quell’età in cui la natura vuole che ti godi i frutti della fatica. E i frutti li ho regalati tutti a te, odiosa città amata, il cui disegno antico tornerà “dov’era” e “com’era” grazie a dieci anni di privazioni della nostra vita. Perché in guerra il sacrificio di un esercito non conta.
Oh, avremmo potuto andare al mare, a fare i passeracci. “Le aquile in tenda, ji passeracci aju mare” dicevano quando ci facemmo deportare sulla costa. I passeracci sono scappati, sono rimaste solo le aquile. Le più coriacee, con la pelle di cinghiale. S’incroceranno tra di loro, e sarà L’Aquila.
Volver 9
Siamo sole, io e Carla, arroccate quassù in cima, dove prima c’erano i bei coppi.
Nel quartiere vivono per lo più anziani, rientrati da poco. Muti e silenziosi, li vedi uscire solo al suono delle campane della chiesa. Tante finestre chiuse sono di quelli che se ne sono andati. Altre finestre chiuse sono di quelli che si sono sistemati più lontano, e non tornano qui a respirare le polveri sottili, e a farsi la giornata al suono delle gru sopra ai cantieri.
Volver 10
Torneranno, quando tutto sarà finito. S’incroceranno anche loro, magari con quegli altri, perché così è la guerra della vita: smazzi con gli stivali in mezzo al fango, muori nella trincea, qualcuno fresco fresco va sul campo, pianta la bandiera.
E dice “noi”.