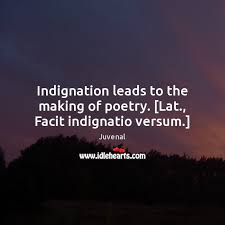Giuseppina è veramente esistita.
Così si chiamava, la “gattara” della Villa Comunale, negli anni Sessanta. Quando le gattare non avevano i gruppi sui Facebook e la gente le considerava delle mezze matte, e forse lo erano davvero.
Il testo, scritto a ridosso del 6 aprile, nasce da una passeggiata sui luoghi della mia infanzia. Cammino, rivivo quello che succedeva. E a un certo punto…..
Arrivava con un’automobile scassata, una Giulietta color sabbia.
Rallentava, accostava al muretto della casa di cortina rossa di Via Filippo Corridoni, spegneva il motore, armeggiava ancora un po’ in macchina. Infine scendeva, maneggiando una rumorosa busta di plastica ricolma di spaghetti al pomodoro. “Miiiicio miciomiciomicio! Miscccch… Nz-nz-nz-nz-nz… Miciomiciomicioooo!”. Iniziava a chiamare con una voce ferma, forte, imponente. Era proprio quello il momento in cui tutti i bambini scappavano a nascondersi dietro agli alberi, o dietro ai pilastri del portico della casa di Serena, un portico ampio, libero, spazioso, pavimentato a mattonelline rosse, ottime per pattinarci sopra. “Schhhhh!!!! Zitti! non facciamoci vedere!” bisbigliava Serena, capo carismatico della banda. Ma lei, la Gattara, sapeva bene che i bambini erano nascosti lì intorno.
Dietro ai vetri delle finestre, nelle case, dietro alle tende, c’erano sempre persone a spiare la Gattara come fosse un alieno. E Lei, che lo sapeva, li controllava feroce, con la coda dell’occhio. Per dispetto alzava la voce: “Miiiiiiiiicio miciomicio! Miscccch… Nz-nz-nz-nz-nz! Venite qui, piccoliniiii! Non abbiate paura di quei brutti spioni… Ci sono io a proteggervi… Venite ciccini… C’è la mamma…”.
Una bimba più di tutti gli altri restava impietrita. Il respiro corto, il cuore che batteva così forte da temere che la Gattara in persona lo sentisse. Potevi addirittura immaginare il modo in cui la piccola cercasse di tacitarlo (“Placati, placati cuore mio, lei non ti può vedere, fatti coraggio, resisti!”). Se faceva quell’effetto sul cuore dei bambini doveva essere proprio vero che la Gattara era un strega. Lo dicevano tutti, perfino il parroco, Don Pasquale. Pare che l’avesse detto in gran segreto alla mamma di Serena. Pure il tabaccaio di Porta Napoli, che aveva il bancone così alto che i bambini non potevano sentire quello che diceva alle loro mamme, pure lui, chiamava la Gattara proprio così, “la strega”. Tutte le autorità del quartiere, parlando di lei, facevano facce strane, o due occhi che pareva dicessero “quella lì”. Dicevano che era pazza, che non aveva nessuno al mondo, solo i gatti della Villa Comunale. Che cosa mai l’avesse trasformata in una gattara, senza neanche più un nome, senza una storia, nessuno lo sapeva, o voleva dirlo.
“Vediamo chi vuole venire a casa mia, stasera… “ minacciava ogni volta la Gattara a voce altissima, per tenere lontani i bambini mentre i gatti mangiavano. E muoveva qualche passo, un po’ di qua, un po’ di là, sbirciando con gli occhi nervosi e cattivi. Quando lei si avvicinava, tutti i bambini scappavano dai loro nascondigli, come stormi di tortore che si alzano in volo dopo uno sparo. Scalpiccio di piedi sul selciato, ali sotto le suole delle scarpe.
Un giorno, per puro caso, proprio la bimba più paurosa riuscì a guardare la Gattara dritta in faccia. Involontariamente, certo, perché fu la Gattara a venire a tiro del suo occhio destro, nascosto perfettamente dietro al tronco dell’albero che la proteggeva. “Vediamo chi vuole venire a casa mia, staseeeera!” aveva detto la Gattara, calcando i passi verso i nascondigli dei bambini. Scalpiccio… voli di tortore… Ma la piccola non era riuscita a muoversi. Era rimasta lì impietrita dalla paura, i piedi cementati a terra e le braccia paralizzate, strette alla corteccia dell’albero, corteccia lei stessa. L’occhio destro, appena sporgente dal tronco dell’albero, era così immobile che riuscì a vederla, solo perché fu lei stessa ad entrare nel suo campo visivo, ed eccola lì davanti, la Gattara: capelli scuri, lunghi appena fin sopra le spalle, frangetta squadrata, occhi truccati pesantemente ma grossolanamente, rossetto acceso, un po’ screpolato, cappotto dal collo sciallato, che di certo ricordava tempi migliori. Gli occhi, marcati di nero, spuntavano fuori nervosi dalla frangia compatta. “Miiicio miciomiciomicio! Miscccch!… Nz-nz-nz-nz-nz…”. Sistemò il sacchetto a terra, lasciando fuoriuscire gli spaghetti e continuando a chiamare i gatti, che iniziarono ad arrivare miagolando di riconoscenza. La Gattara si accorse della bambina dietro all’albero. Oh… Di sicuro l’avrebbe presa e portata via come recita la filastrocca dell’Uomo Nero! L’avrebbe presa e chiusa in una gabbia dentro alla sua Giulietta scassata, per poi cucinarla nel sugo degli spaghetti per i gatti! La bimba serrava le palpebre sugli occhi, sentiva la saliva riempirle la bocca, non aveva neanche il coraggio di inghiottire.
“Questi bambini sono molto maleducati” disse invece la Gattara ad alta voce, camminando solennemente verso di lei. “C’è solo una bambina coraggiosa, in questo quartiere…”. Stava parlando di lei? Il cuore della piccola voleva scoppiare, oppure fermarsi, fatto sta che quelle parole ebbero lo strano effetto di convertire la paura in una strana emozione, forte e bella quanto prima la paura era stata terribile e distruttiva. “Solo una bambina non è scappata via…” gridò la Gattara, per farsi sentire dagli altri bambini. “…L’unica bambina in gamba in questo posto pieno di sbruffoni!”.
La bimba ricominciò a respirare, sentì il sangue scorrere di nuovo, i muscoli delle gambette secche rilassarsi. Poi la Gattara aggiunse, a voce così bassa che solo la bimba poté sentirla, e non lo raccontò mai a nessuno al mondo: “… Quei mentecatti dietro ai vetri mi danno della pazza… mentecatti… Piccoli topi miserabili… state alla larga dalla Gattara, state alla larga, miserabili topi…sciò!”. E raccolse il sacchetto ormai quasi vuoto, rovesciando gli ultimi spaghetti per terra. “Miiiicio miciomiciomicio! Miscccch… Nz-nz-nz-nz-nz… Andate a nanna gattini, su, fate i bravi… E state lontani dai cani… i cani ah!”.
A questo punto, la Gattara si girò verso la bimba nascosta. L’occhio destro della piccola non osò neppure sbattere la palpebra, così la fissò dritta in quegli occhi felini, neri come due olive nere. E la trovò bellissima. E pensò che era una fata.
Quel giorno la Gattara aveva detto a tutti che quella bambina era la più coraggiosa del quartiere, e da allora in effetti la bambina iniziò a diventarlo, ogni giorno di più. Si diventa sempre quello che una fata dice agli altri che tu sia.
“Miiicio micio micioooooooo! Mischhhh… Nz nz nznznz…”
Non c’è più nulla, in via Filippo Corridoni, ora.
Arrivo, spengo la macchina, e chiamo.
“Miiicio miciomiciomicio! Mischhh!…”
Rovescio la mia busta di spaghetti a terra, loro arrivano, sono pochi, tre o quattro, i pochi rimasti qui dopo il 6 aprile di tre anni fa. Sono riusciti a salvarsi dal crollo della casa con la cortina rossa, la casa di Serena, che si è seduta sul suo porticato, sbriciolata, sprofondata, ingoiata dalla terra, lei, il suo portico con il pavimento di mattonelle rosse su cui noi bambini si pattinava.
“Venite, piccini… nznznznz… Venite, su!”
Non c’è più nessuno che guarda da dietro le tende. Sono morti, ingoiati dalla terra. Oppure scappati via. Posso sentire lo scalpiccio dei piedi che corrono, volo di tortore dopo lo schioppo, ali sotto le suole delle scarpe… I gatti, però, sono rimasti. Sporchi, smagriti, selvatici, piccole linci selvagge, arruffati, soli.
“Miciomiciomiciomicio!… Nznznznznz… Mischhhh!”.
Venite qui, piccini, la Gattara vi nutre, vi porta acqua da bere. Siete stati bravi, siete stati coraggiosi a restare in questo posto.. Venite, la Gattara vi protegge, perché siete rimasti qui senza casa, senza cibo.
I gatti mangiano avidamente, io riempio di acqua una grossa ciotola di plastica.
La polvere delle macerie mi secca la bocca, la sento nella gola. Sono passati tre anni.
E non c’è neanche una bimba, dietro un tronco d’albero, a guardarmi con il suo occhio destro sbarrato. Neanche una bimba, in via Filippo Corridoni, a vedere la Gattara come una bellissima fata senza storia.

______________________________
Buddy Guy – Black Cat Blues